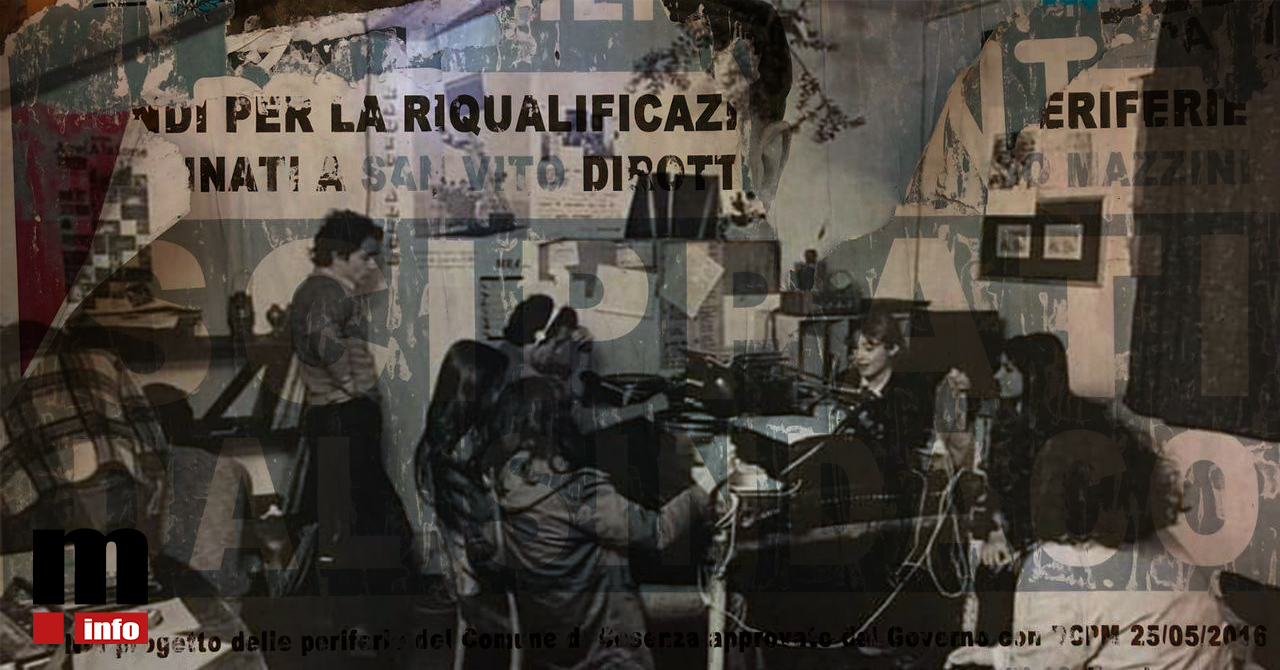Quello che segue è il secondo saggio (il primo è consultabile sulla nostra rivista qui) di Mario Tronti pubblicato nel 1968 sulla rivista Contropiano diretta da Alberto Asor Rosa e Massimo Cacciari e fondata proprio in quell’anno. Tronti vi pubblica solo tre articoli, ritagliandosi, probabilmente per scelta, un ruolo più defilato rispetto a Classe Operaia e Quaderni Rossi.
I tre articoli, Estremismo e riformismo (CONTROPIANO, N. 1/1968, pag. 41-58), Il partito come problema (CONTROPIANO n.2/1968, pag. 297-317) e Internazionalismo vecchio e nuovo (CONTROPIANO, N. 3/1968, pag. 505-526) rappresentano una lunga e attenta disamina su alcuni concetti quali l’organizzazione, la teoria del partito, la funzione del sindacato e il ruolo del movimento, soprattutto quello studentesco. In calce al primo articolo lo stesso autore scrive: Questo discorso avrà un seguito, probabilmente in due parti: una dedicata a quella che si dice la teoria del partito, con annesso il problema del sindacato, oggi; l’altra dedicata a quella che si dice la strategia internazionale della lotta di classe, compreso il momento mondiale odierno del movimento operaio. Necessariamente i testi proposti risentono del periodo storico e politico nel quale sono stati prodotti ma ancora oggi, in essi, si possono individuare elementi di assoluta attualità che ci hanno spinto alla pubblicazione sulla nostra rivista.
Quello che segue, Il partito come problema, è il secondo dei tre contributi.
* * * * * *
IL PARTITO COME PROBLEMA
Ci sono momenti in cui sale lo scontro di classe, mentre arriva ancora a muoversi nella forma del partito: momenti in cui, mutati i contenuti delle lotte operaie, non c’è niente nella vecchia organizzazione che riesca a registrare le condizioni nuove. Dagli anni trenta ad oggi abbiamo vissuto un lungo momento, un’epoca, di questo genere. Gli operai a contatto diretto con l’iniziativa capitalistica, dopo la grande crisi, hanno via via modificato la gerarchia interna delle loro rivendicazioni, fino ad assumere il cammino più corretto e il modo d’attacco più efficace di tutta la storia della lotta di classe, quello che oggi si riassume nella parola d’ordine: dal salario al potere. II partito rivoluzionario, il movimento comunista, era nato sull’indicazione opposta – che bisognasse prendere il potere per migliorare le condizioni di vita dei lavorala -, e anche quando ha modificato questa prospettiva, non ha mai avuto il coraggio di rovesciarla. Che puntando la lotta sul salario, sulle condizioni economiche degli operai nel capitalismo, e ottenendo successi su questo terreno, si possa arrivare non a stabilizzare ma a mettere in crisi l’attuale macchina politica del capitale, – è questa l’ipotesi sempre più ricca di fatti che mette in situazione critica la presenza del partito così com’è e rende problematica la sua stessa sopravvivenza. Non esiste d’altra parte un modello già pronto di nuova organizzazione, tanto meno quindi la possibilità di una sua esistenza già tutta dispiegata. Esistono solo tutte le ragioni di una ricerca, tutte le condizioni di una sperimentazione, che offra un ponte di transito tra il vecchio e il nuovo, un punto di contatto storico, un rapporto, una struttura intermedia di passaggio dalla più vicina e più praticabile forma di partito agli ultimi altissimi e avanzatissimi livelli di classe.
Poniamoci la domanda: è necessario oggi rivedere e aggiornare quella che si dice la «teoria del partito»? Pochi, credo, avranno il coraggio di rispondere no a questa domanda. I cosiddetti dogmatici sono in fondo solo dei revisionisti che si vergognano. Per quanto li riguarda sono disposti a cambiare la forma del partito se rimane intatta la sostanza del loro potere. I revisionisti espliciti, invece, i riformisti moderni, sono i più pronti ad assumere l’istanza di un aggiornamento nella teoria dell’organizzazione, sulla base dei bisogni più recenti del capitale, sull’onda delle sue più correnti ideologie. È di nuovo per sfuggire a queste vecchie alternative che noi vogliamo rimettere in discussione il concetto stesso di «teoria del partito». Se teoria, dal punto di vista marxista, si dà di un fatto reale della produzione, che si mostra permanente per tutto l’arco di esistenza di una formazione economico-sociale, e condiziona le condizioni sociali, e impone una sua vita autonoma nei confronti dell’insieme, in termini di lotta, di insubordinazione, di antagonismo, – allora si dà teoria di una classe e non della sua organizzazione formale. Se teoria è conoscenza e giudizio di una parte sul tutto, della classe sulla società, se è non solo coscienza di classe ma coscienza della lotta di classe, – allora si deve parlare di punto di vista operaio sul capitale e non di quel balordo concetto di «partiticità», che a pensarci bene era inevitabile si riducesse al punto di vista del partito sui fatterelli della vita quotidiana. Estremismo e riformismo che in comune hanno l’assenza di una teoria della classe operaia, in comune hanno anche la presenza di una teoria del partito. E non si sa chi ha combinato più guai, se l’idea socialdemocratica di una organizzazione aperta per la raccolta del consenso e per la gestione del potere nell’interesse generale, o la teoria bolscevica del partito come circolo chiuso di rivoluzionari di professione che vanno in mezzo al popolo per sollevarlo, secondo la codificazione di principio del catechismo staliniano. Ma una sola classe, tanti partiti: questo è e rimane il fatto decisivo. Che la storia interna della classe operaia possa dar luogo a un concetto di classe che leghi insieme le fasi passate e preveda e prepari quelle future, – questo è il lavoro di oggi del pensiero teorico. Ma che le molteplici forme del partito, fin qui vissute e tuttora in gran parte conviventi (perché niente più del partito si presta ad essere eredità passiva) diano poi luogo a quella forma che più ci serve in questo momento, – questo è un fatto pratico, un’azione politica, un lavoro sulle cose. Altrimenti sarebbe come prendere per buona e adattare ai nostri bisogni la pretesa di parte borghese a una «dottrina dello stato»: e riconoscere così autonomia a una realtà che per definizione è derivata, non ha vita propria, vive di luce riflessa. Il partito non ha, non può, non deve avere autonomia rispetto alla classe: questo è l’unico punto teorico fermo, che può essere elaborato, ma mai, in nessun caso, né rivisto né tanto meno negato. Per il resto, teoria della classe e pratica del partito è il primo ancoraggio di metodo su cui bisogna fermare la ricerca.
Pratica del partito, ovvero ricerca di quella forma di partito che più ci serve in questo momento: vediamo se è un modo corretto questo di porre il problema. Non è il caso di impegnarsi adesso in una professione di fede metodologica. Ma certo bisogna partire dal fatto che il problema del partito ha per sua natura una soluzione di breve periodo, non in senso assoluto ma relativamente ad altro e l’altro in questo caso sono i problemi più direttamente di classe che seguono il passo delle grandi epoche storiche. La soluzione va cercata quindi già in una dimensione temporale provvisoria, con una autolimitazione nel tempo, che non può certo essere calcolata al millimetro, ma che deve tenere in sé una controllata approssimazione. Va cercata inoltre in uno spazio geografico ben delimitato, non in senso grettamente nazionale, come capita oggi spesso di sentire, ma sulla base di una situazione di classe omogenea, che copre livelli di lotte se non eguali, almeno simili tra loro. Dire una volta per tutte e come principio valido per tutti: ecco il partito della classe, – è non solo errore di metodo, è errore pratico, politico, che si paga duramente sul tempo lungo della lotta. Non sappiamo ancora se dal punto di vista operaio dovrà elaborarsi un nuovo moderno concetto di «politica», se l’attività pratica in senso sovversivo dovrà essere sistemata secondo nuove leggi. Sul momento tutto lascia credere di no. E a questo punto siamo quasi convinti che leggi della tattica non se ne possono dare, a meno di non dare veste strategica, e quindi significato non politico, al comportamento pratico. Il problema è sempre quello di trovare i modi concreti di organizzazione delle forze in lotta in questo momento dato e nello spazio che ci è concesso. Per questo occorre cominciare a mettere in circolazione una figura del partito come armamento leggero della classe, che si possa in breve assumere e in breve abbandonare, che dia duttilità di movimento e rapidità di esecuzione alle istanze di base, che abbia in sé quella capacità di autocontrollo che lo spinge a cambiare forma man mano che i nuovi livelli di sviluppo degli operai impongono mutamenti all’iniziativa del capitale. Il partito come funzione della classe non basta: questa funzione deve ora diventare una struttura elastica, agile, moderna, aggiornata, facile da usare, maneggevole cioè nel suo meccanismo consapevolmente provvisorio, e soprattutto ricca di complesse articolazioni.
L’articolazione non sarà soltanto e non sarà tanto nel partito, ma del partito con altre istanze organizzate, da esso autonome e con esso, diciamo così, alleate. Il concetto di alleanze sembra più propriamente spostarsi oggi dal terreno sociale a quello istituzionale. Un blocco storico, nel senso appunto di organica alleanza politica, e più facile oggi che si realizzi tra forze istituzionalmente diverse, ognuna nel proprio campo organizzata, che tra ceti sociali spontaneamente in lotta ognuno per i propri particolari interessi. Alla società del pluralismo democratico non si può rispondere con il settarismo di un’organizzazione unica e monolitica, rappresentante degli interessi di più classi e della nazione intera. Occorre anzi avere più pedine da muovere, contemporaneamente e nella stessa direzione, più forze organizzate da impegnare, alcune subito e in primo piano, altre di riserva e come sorpresa per l’avversario. Tutto lascia prevedere che ci troveremo a che fare, nel periodo immediatamente prossimo, non con una guerra di posizione, ma con una guerra manovrata e di movimento. Gli sviluppi degli ultimi anni, le vicende degli ultimi mesi indicano questa direzione oggettiva. Ma anche se così non dovesse essere, bisognerebbe comunque imporre soggettivamente al nemico di classe questa condotta nella lotta, perché è quella che più lo mette in difficoltà, lo costringe alla difesa, toglie spazio alla sua iniziativa, gli lascia come unica via d’uscita la risposta disordinata di chi sa che non può non perdere. Al partito spetta di esercitare l’egemonia più che la direzione sulle forze alleate. E l’egemonia è fatta di consenso spontaneo, e questo va fondato sul prestigio, sulla maggiore capacità di analisi e di coscienza della situazione complessiva, sulla migliore possibilità di incidere in forme aggressive sul potere del capitale: tutte cose che restano in mano al partito quando il partito funziona. Su questo terreno esterno i vecchi metodi di direzione sono invecchiati più in fretta che all’interno del partito, non funzionano più, vengono rifiutati con una giusta violenza. Da qui bisogna andare avanti a stabilire dovunque, dentro e fuori il partito, nuovi rapporti tra chi momentaneamente si trova a dirigere e chi momentaneamente è diretto. Uomini nuovi devono continuamente salire al vertice del movimento e fare esperienza di sé, a rinnovare tutto. È per la sommità del partito che vale prima di tutto la parola d’ordine: bisogna cambiare!
Il sindacato è il primo degli «alleati» del partito. Il supporto tra i due, le reciproche competenze, la diversità dei compiti e al tempo stesso il terreno di classe che li unisce e talvolta li confonde, sono questi i problemi di sempre che oggi hanno avuto un decisivo e speriamo fecondo ritorno di attualità. A noi sembra che tra sindacato e partito non si possa parlare di un diverso terreno di lotta, ma di una diversa estensione di questo terreno. L’uno e l’altro vivono e lottano – devono vivere e lottare – sul campo della produzione sociale. Il sindacato gestisce quei contenuti della lotta che si rivolgono contro il padrone singolo o contro la somma dei padroni singoli. L’organizzazione sindacale padronale cura niente più che l’associazione degli interessi economici dei singoli capitalisti: è questo che gli dà forza politica; ma non bisogna confondere la confindustria con lo stato, come si fa spesso, rozzamente, da sinistra. Così, similmente, restano in mano al sindacato operaio la difesa del livello elementare della forza-lavoro, i tempi di lavorazione del prodotto, l’orario, i cottimi, ma anche tutto il resto, compreso il salario. Il sindacato gestisce nella sua tensione tutta la lotta e ne assicura la continuità. Il partito sceglie tra i contenuti della lotta quello che ha la maggiore incidenza sull’iniziativa politica del capitale nel suo complesso e fin un particolare momento. Sceglie e revoca a sé e prende in mani proprie quel contenuto spontaneo della lotta operaia che investe direttamente ed è capace di mettere in crisi l’equilibrio statuale, la stabilità politica del potere capitalistico: cosa che deve risultare dall’analisi scientifica del proprio avversario di classe, dal calcolo esatto delle forze in campo, dalla misura del livello dei bisogni della propria parte. Il sindacato comprende e tiene presente tutti i contenuti della lotta, ma tutti dentro il terreno della produzione diretta, arrivando al massimo alle condizioni sociali in cui si presentano i problemi operai: nella fabbrica e dalla fabbrica alla società. Il partito isola uno di questi problemi, volta a volta politicamente determinato, e lo porta dalla fabbrica alla società fino allo stato. Uno di questi problemi, una di queste richieste operaie di base, uno di questi bisogni collettivi di massa, in grado oggi di coprire tutta la traiettoria che porta la minaccia di sovversione nel cuore del sistema, – è il salario. Sul salario operaio, non solo da oggi, è possibile e diventa sempre più necessaria una lotta| politica generale, in cui il partito impegna i quadri della propria organizzazione e verifica la sostanza della propria linea di alternativa al sistema, con un attacco a fondo non alla politica economica del governo ma alla stabilità politica dello stato negando il controllo capitalistico sui redditi da lavoro, facendo saltare prima ancora che il piano nel suo complesso, le sue stesse premesse di valore. Questo vuol dire la frase in sé non del tutto chiara: il salario in mano al partito.
Di questi tempi non si può parlare di sindacato senza parlare di autonomia e di unità. Bisogna dire subito che anche dal punto di vista qui trattato l’autonomia e l’unità del sindacato non sono delle concessioni tattiche, sono e devono essere, meno oggi, vere e proprie scelte strategiche da parte del partito. L’autonomia assicura al sindacato la funzione di specchio delle condizioni della forza-lavoro in un dato momento, riflesso diretto e immediato, misura economica, quantitativa, della situazione di classe della forza-lavoro, dei suoi bisogni elementari di fronte al padrone. L’unità sindacale, oltre a rendere possibile una vera autonomia, garantisce una visione appunto unitaria dei problemi dei lavoratori, media già in sé e ricompone in una linea di tendenza unica rivendicazioni specificamente operaie e rivendicazioni genericamente lavoratrici, cercando e trovando un’espressione di nuovo economica delle rispettive istanze politiche. Il partito ha bisogno di questa conoscenza diretta e subito complessiva della situazione di classe a livello economico-materiale, ha bisogno del sindacato per averla. Il sindacato è infatti specchio della spontaneità operaia; e non solo di quella operaia, ma anche dell’iniziativa padronale diretta sul luogo di produzione. Solo su questa base materiale il partito può costruire una politica di classe. È chiaro che perché il sindacato serva in questo modo al partito deve poter seguire tutto quanto e in piena libertà il suo compito specifico, funzionare quindi concretamente come organo di difesa della forza-lavoro di contro all’iniziativa padronale e come strumento di attacco delle richieste operaie al potere economico capitalistico. Il sindacato in quanto arma della lotta economica operaia assolve già e tutta intera la sua funzione politica e non ne deve cercare nessun’altra.
Si pone il problema: questo specchio sindacale non serve anche al capitale per conoscere i movimenti oggettivi della forza-lavoro e per aggiornare quindi la iniziativa politica generale sul terreno di classe? Il sindacato non diventa così un istituto neutro di ricerche sociali? o peggio una struttura formalizzante del problema di classe a favore di chi tiene il potere? Il pericolo dell’istituzionalizzazione è reale. La funzione istituzionalizzante che il sindacato esercita sulle lotte operaie per conto del capitale, in una parola l’uso capitalistico del sindacato, non è un’invenzione fantastica di gruppetti estremisti, è una scoperta scientifica di forte impronta marxista. È l’altra vera e reale faccia del sindacato a livello di capitalismo sviluppato. Questa faccia non si potrà mai completamente cancellare; ma come si può ridurre a fatto secondario? Come si può caricare di senso politico opposto l’organizzazione capitalistica della forza-lavoro? Due condizioni sembra necessario a questo proposito predisporre e salvaguardare. La prima riguarda la struttura democratica del sindacato al suo interno: la spinta dal basso verso l’alto deve essere più forte del controllo del vertice sulla base; il vertice di qualsiasi organizzazione in una società capitalistica è sempre pericolosamente sensibile alle necessità del capitale; per correggere questa tendenza non c’è altra via che curare di tenere sempre bene aperti i canali di passaggio delle richieste operaie di massa; oggi torna di moda l’assemblea operaia ed è una fortuna, ma bisogna stare attenti, la democrazia diretta così come stanno le cose non è un modo molto efficiente di direzione e di organizzazione; non si tratta di negare qualsiasi funzione ai dirigenti come tali; per adesso si tratta ancora di cambiare quelli che non si possono utilizzare e di utilizzare quelli che non si possono cambiare. La seconda condizione si chiama partito di classe fuori dal sindacato: l’iniziativa politica sempre in mano al partito e attraverso il partito in mano alla classe operaia; strategia di attacco al potere del capitale, mai sulla difensiva, mai dare tregua; spostare sempre in avanti gli obiettivi in modo che quello che viene istituzionalizzato dal capitale sia già il livello passato, quello immediatamente precedente, dell’organizzazione materiale della forza-lavoro, mentre il livello presente e quello che sta per sopraggiungere deve sfuggire alla conoscenza e alla presa del capitale stesso; la forza della previsione deve rimanere gelosamente in mani operaie, attraverso lo strumento dell’organizzazione politica; l’istituzionalizzazione capitalistica deve essere condannata a un generico riflesso di ciò che irrimediabilmente è stato.
Cade qui un appunto di metodo sulla differenza concettuale tra organizzazione e istituzionalizzazione. Specialmente dall’interno delle forze giovanili oggi in lotta è facile notare una certa confusione su questi concetti. Ogni e qualsiasi tipo di organizzazione, anche propria, anche fatta da sé stessi, viene rifiutata per i pericoli che presenta di essere strumentalizzata dall’avversario, attraverso i canali ufficiali di un movimento di opposizione formale. C’è qui un’istanza di principio giusta e corretta, di chiara origine operaia. Anche gli operai, quando non c’è ancora lo scontro di massa, quando si tratta di prepararlo, quando il nuovo ciclo di lotta è agli inizi e si devono raccogliere le forze e stabilire i piani d’attacco, – anche gli operai non li troverete disposti a scoprire le carte di fronte al padrone, a prefigurare cioè in modo aperto le forme della loro prossima struttura organizzata. Ma la lotta operaia si iscrive sempre in una continuità di organizzazione che non viene mai bruscamente interrotta: e qui sta la differenza. Gli operai possono permettersi il lusso di non passare alla nuova forma di organizzazione finché possono usare lo strumento di quella vecchia. Ma chi deve pensare per la prima volta a organizzarsi, chi dietro di sé non ha modelli se non da distruggere, chi dunque non ha tradizione di organizzazione, allora non può tardare a salire ai nuovi livelli adatti a un movimento che vuole camminare sulle proprie gambe, reggersi cioè su proprie strutture, lasciando alle neo-avanguardie artistiche, che se lo meritano, il gioco intellettuale dei discorsi «informali». Il ritardo nel passaggio all’organizzazione può compromettere oggi la crescita del nuovo movimento giovanile, la sua maturazione politica, la sua funzione prossima di forza d’urto dello schieramento di classe contro il sistema del capitale. Accettare l’organizzazione, rifiutare l’istituzionalizzazione: questo è il programma. Riuscire a costruire una struttura funzionante di espressione delle esigenze di massa e di direzione della nuova spontaneità senza lasciarsi iscrivere nell’elenco delle associazioni che ufficialmente raccolgono le spinte di base e pacificamente le convogliano nel mare inquieto dello stato borghese: questo è il problema. Con ciò non vogliamo dare credito alle illusioni della guerriglia cittadina nelle metropoli del capitalismo, o peggio, alle romanticherie dell’apparato semiclandestino che sempre ricorrono di fronte alla dura realtà della repressione poliziesca. Ripetiamo che tutto intero il terreno democratico tradizionale va utilizzato fino in fondo, e che è la possibilità di questa utilizzazione che va prima di tutto imposta all’avversario. Organizzazione senza istituzionalizzazione vuol dire autonomia e libertà di movimento per forza propria e non per graziosa concessione della carta costituzionale, vuol dire imporre anche sul terreno formale la presenza organizzata di una potenza politica alternativa senza che il sistema ne faccia un elemento di stabilità dei suoi meccanismi autoregolatori, vuol dire controllo alla luce del sole della crescita del movimento di classe ma dal solo punto di vista operaio, mentre il capitale non deve vedere, non deve capire, soprattutto non deve poter utilizzare quel poco che per sbaglio, e di riflesso, a stento, riesce a vedere e a capire.
Il mondo giovanile in genere e il movimento studentesco in particolare sembrano oggi il campo più proprio di sperimentazione di un’organizzazione non istituzionalizzata. Una larga fascia di questo mondo e di questo movimento vive ora un momento di tensione acuta e di estrema ribellione nei confronti del modo di vita capitalistico. Guai a non rilevare il fenomeno nella sua consistenza e a non inserirlo nei programmi di attacco al sistema. Non si tratta di teorizzare una condizione giovanile eternamente in lotta col presente e su questa base con diritto a una perenne positiva autonomia; né tanto meno si tratta di fare la minima concessione alle nuove ideologie premarxiste sui giovani «come classe», che avrebbero raccolto dalla polvere le bandiere rivoluzionarie lasciate cadere dagli operai ormai integrati, – patetiche senilità marcusiane che bene si incontrano con le presunzioni infantili di ogni movimento agli inizi della sua storia. Le cause di questa tensione giovanile noi diciamo che sono politiche, quindi con una forte immediatezza, quindi di breve periodo. Non c’è spazio qui per discorsi strategici, per visioni storicistiche. Tutto nasce da questa crisi di oggi dell’iniziativa capitalistica a livello mondiale, tanto più grave in quanto vera e propria crisi di ritorno, dopo che le soluzioni nuove, queste si di lungo periodo, erano state intraviste e appena impostate nel cervello del capitalismo internazionale, negli Stati Uniti, sulla base del primo esperimento kennedyano. Crisi quella di oggi non della macchina economica che produce profitto, crisi non ancora delle strutture statuali che garantiscono l’equilibrio, ma crisi appunto politica nel senso più tradizionale del termine, assenza di iniziativa, mancata comprensione dei fenomeni nel loro complesso, attività puramente tecnica dei ceti dirigenti e passività di fondo e sulla prospettiva. È ormai provato che senza una sua propria strategia mondiale il capitale vive una vita molto inquieta. Non a caso il riverbero di questa crisi lo troviamo con tanta violenza proprio in quelle parti del corpo sociale che più direttamente sono a contatto con le forze stesse della crisi: gli studenti sono i più vicini al ceto politico. Non è allora la solita rivolta dei figli contro i padri, è un preciso e determinato processo di invecchiamento politico dei gruppi dirigenti al vertice dei due massimi sistemi di fronte alla nascita e alla crescita di nuovi problemi, di nuove intelligenze adatti a capirli, di nuove forze pronte per risolverli. Spaventosa è l’arretratezza del livello politico formale dinanzi alla sostanza moderna dello sviluppo civile, cioè, diciamo pure, dello sviluppo economico. Il divario politico tra società e stato, tra sviluppo e potere, è oggi una contraddizione di fondo che coglie tutta intera la vita del capitale, supera la divisione in blocchi contrapposti e riunifica potenzialmente le linee maestre del discorso alternative. Sono fallite le grandi risposte ai piccoli problemi. E non è vero che i giovani hanno fame di ideali. Per fortuna, non ne vogliono più sapere. Vogliono cose concrete ma esplosive, armi leggere ma mortali per il sistema di vita che li circonda. Orazioni in morte del capitale ne hanno sentite tante, ma articolate azioni materiali per batterlo sul suo proprio campo ne hanno viste poche e sanno che qui c’è ancora tutto da inventare. Solo ora il terreno sembra aprirsi e si dà forse l’occasione del vero grande balzo. A ben guardare, la situazione è eccellente, per dirla in linguaggio cinese. Il gioco è fatto, perché tutti i miti sono caduti. Le nuove frontiere del modo di vita americano si erano da tempo impaludate nelle risaie del sud-est asiatico quando s’è pensato di celebrare i cinquant’anni di potere sovietico puntando i cannoni dell’armata rossa sui comunisti di Praga. A questo punto, chiedete ai giovani d’oggi che cosa sono per loro capitalismo e socialismo. Vi diranno: vecchie risposte a nuove domande.
Un movimento giovanile, né a livello operaio né a livello studentesco, può mai avere autonomia rispetto ai movimenti delle forze produttive sociali nel loro complesso: è qualche cosa che sta in mezzo tra il potere specifico di queste forze (le classi) e l’opinione pubblica generica (quella che si dice impropriamente la società civile), porta su quest’ultima la spinta in quel momento vincente sul terreno della lotta di classe. Attraverso l’immagine riflessa sullo stato attuale del movimento giovanile tutti possono vedere come e quanto viene aggredito oggi il sistema del capitale, come e quanto sia in crisi l’iniziativa dei capitalisti riguardo al governo della loro società. In una moderna articolazione pluralistica delle forze di classe, a livello politico formale, l’organizzazione della rivolta dei giovani è, con una lunga provvisorietà, un momento adesso essenziale. Un movimento politico giovanile unitario, non di partito, ma alleato del partito, accanto al sindacato, è appunto una di quelle armi semplici e offensive richieste dal nostro tempo. Il suo posto non è tra la classe e il partito: tra classe e partito il rapporto deve essere diretto, senza mediazioni. Il suo posto è tra partito e stato quando sono ancora divisi, prima della presa del potere, e tra lo stato e le masse dopo. La sua funzione e cioè eminentemente politica, non sociale, – strumento di classe solo indirettamente. La fabbrica è per i giovani la loro propria università di classe, non il luogo di organizzazione specifica dei loro propri interessi. Gli studenti che vanno verso gli operai devono consapevolmente andare alla scuola della lotta di classe, e niente più di questo o poco più di questo: mai cadere nella presunzione di dirigere le lotte mai nell’illusione di portarle ad uno sbocco, come si dice, «politico». Per i bisogni di oggi basta concepire la nuova forza giovanile come un fatto di movimento, un’organizzazione per sua natura dinamica, un canale di comunicazione politica sempre rinnovantesi, uno strumento di conoscenza delle esigenze nuove chi maturano in basso e in più fucina di quadri politici per il partito, ma qui non nel senso vecchio del funzionario che raggiunti i limiti di età diventa pensionato in un ufficio della direzione, ma nel senso di una continua crescita di dirigenti nuovi che sostituiscono quelli vecchi man mano che questi diventano inutili, sorpassati, ridicoli. Un’organizzazione giovanile unitaria, autonoma, indipendente dal partito e una necessità di oggi dello schieramento di classe. Come non si tratta di condannare in astratto il sindacato-cinghia di trasmissione, ma di riconoscerlo come la necessità storica di un periodo ormai passato per sempre, così si tratta di vedere nelle federazioni giovanili comuniste una forma di organizzazione che ha fatto il suo tempo e che ora non serve più. Tra i giovani il partito ha bisogno adesso di uno stimolo esterno e contraddittorio, per conoscere le cose nuove e prevederle, per aggiornare continuamente la propria linea, per rinnovare sempre e con facilità il proprio quadro dirigente. La massima autonomia deve essere quindi assicurata al movimento giovanile. Conviene puntare sulla spontaneità nel medio periodo del rifiuto e della rivolta a livello di masse giovanili: educare semmai queste masse al senso geloso dell’organizzazione autonoma dei propri movimenti spontanei, al gusto dell’opposizione sempre organizzata al sistema di potere in quanto tale, da chiunque cioè esso sia gestito, compresa dunque la gestione del partito. Per la lotta presente degli studenti e dei giovani il termine di opposizione extraparlamentare e abbastanza corretto: anche se solo con significato negativo, rende bene il senso di una opposizione di tipo nuovo non istituzionalizzata, eppure organizzata, proprio per questo sensibilissima, viva, mobile, attiva, non formale ma reale. Di nuovo, e anche da questa parte, per la dirigenza di partito è tempo invece di ricostruire tutto un nuovo modo di direzione politica. E ammettiamo pure che ci vuole coraggio. Riconoscere che un’organizzazione amica, quando esiste, sa dirigersi da sé e deve dirigersi da sé, che le masse in certe occasioni sono più mature dei loro capi presunti, che gli alleati della lotta bisogna saperseli conquistare con il prestigio delle proprie azioni e non con l’imposizione delle proprie verità, che quando si comincia a rimanere indietro bisogna allora rinunciare a stare avanti, perché vuol dire che per essere noi i dirigenti il tempo è scaduto, – riconoscere questo è qualcosa d’altro simile a questo è di nuovo una di quelle cose che spingono il movimento comunista ad andare oltre il movimento comunista, al di là di se stesso, verso nuove esperienze di organizzazione. Come camminare effettivamente in avanti, come non tornare indietro verso soluzioni liberali o democratiche, mensceviche o socialdemocratiche, – questo è il problema di oggi che ancora non ha soluzione.
La soluzione va prima di tutto cercata nell’ambito del rapporto partito-classe. È il punto più delicato e al tempo stesso il più decisivo. Da quando Lenin ha detto «non si deve confondere il partito, reparto d’avanguardia della classe operaia, con tutta la classe», è passato molto tempo. Che cosa rimane valido di questa affermazione? Come si può riparlare di reparto d’avanguardia, se la scissione partito-classe è avvenuta proprio sul fatto che il partito è rimasto indietro rispetto alla classe? se negli ultimi decenni politica e organizzazione del partito non sono riusciti non dico a precedere ma neppure a seguire i movimenti di lotta della classe? Certo, l’identificazione tra partito e classe non è tuttora possibile, neppure nei punti più alti dello sviluppo; si potrebbe dire che non è ancora matura, non esistono ancora le condizioni sociali, le premesse politiche per la sua realizzazione, e forse non esisteranno mai; è purtroppo ancora no la risposta alia domanda leninista: ogni scioperante può considerarsi membro del partito? D’altra parte la concezione bolscevica del piccolo, chiuso, ma agguerrito gruppo avanzato di rivoluzionari professionisti che decidono per la classe, in quanto parte più cosciente, e talvolta sola parte cosciente di essa, è ben superata dai fatti, non corrisponde più ai tempi, rimane legata a condizioni storiche precise e irripetibili, e da ultimo continua ad essere fonte di tali, come si dice, «tragici errori», che non è il caso di farla sopravvivere oltre. Dunque, il partito non può essere ancora tutta la classe, d’altra parte non può essere più solo una parte della classe: questo è oggi il problema del partito. Accanto all’inattualità delle concezioni classiche sta il fallimento di tutti i loro aggiornamenti. Le soluzioni cosiddette moderne sono sempre le meno nuove, sono state sempre aggiustamenti dell’organizzazione per far passare la rinuncia alla lotta. Le svolte di Salerno sono solo servite a portare alle ultime conseguenze pratiche le premesse sbagliate di un discorso teorico fatto una volta per tutte. La vecchia soluzione al problema del partito è stata aggiornata, non superata, adattata cioè a condizioni nazionali diverse, come fosse legge universale valida per sempre e dappertutto. È un vizio storico del movimento comunista che sembra non ancora superato: richiamarsi all’autorità ultima in ordine di tempo per cambiare tutto senza cambiare niente. Si trova sempre nell’oggi la conferma a quello che s’era detto ieri. Mentre l’esperienza politica consiglia e la condizione dell’oggi del rifiuto e della protesta ci insegna che quello che vai ripudiato è sempre il proprio immediato passato, quello che s’è fatto poco prima e che risulta sempre incredibilmente invecchiato rispetto a quello che facciamo ora. Nella polemica col presente, per chi non vuole ricorrere ai futuribili utopici ora di moda, il passato remoto è semmai più del passato prossimo ricco di possibilità pratico-critiche. In questo senso, la riscoperta di Marx, quando adesso viene dalle giovani generazioni è un fatto polemicamente positivo di avanzamento e di svolta; il ritorno a Lenin, da parte degli eredi di Stalin, è stato uno sprazzo di audacia politica, fecondo, se fosse stato veramente praticato, di grandi imprevedibili sviluppi; ma il querulo richiamo a Togliatti dell’attuale dirigenza del partito è solo segno di pigrizia mentale e prova di una impressionante mancanza di fantasia. La storia ultima del movimento comunista in occidente non gioca certo oggi come campo di riferimento positivo per le forze rivoluzionarie. L’epoca post-leninista non vogliamo dire che sia qui da noi una sequela di errori; può darsi anche – questo bisogna sempre essere pronti ad ammetterlo – che non si potesse fare altrimenti. Ma una cosa preliminare bisognerebbe intanto ammettere insieme: sembra veramente che vada chiudendosi, con ritardo ma per sempre, quel periodo storico che prese le mosse dal VII congresso dell’Internazionale, quando l’intera organizzazione del partito venne adattata alle esigenze della lotta contro il fascismo e a difesa del socialismo in un solo paese. Bisogna studiare a lungo questo periodo, puntando su di esso le armi della ricerca, recuperando quella parte di eredità che neppure noi respingiamo, ma senza false pacifiche continuità, anzi con quel gusto della rinuncia permanente alla propria tradizione, anzi con quella ricorrente decisione di rompere col proprio passato, che deve sempre sorprendere l’avversario, deve tenere sempre giovane e vivo il nostro movimento, deve in una parola diventare, da questo momento in poi e per la prima volta nella storia degli apparati organizzativi, la caratteristica politica dominante dell’organizzazione di classe della lotta operaia.
Andiamo dunque verso una forma di partito aperto? È presto per inventare formule nuove al posto di quelle vecchie. Se è vero che quello del partito è un vecchio problema che cerca una soluzione nuova, – allora conviene per adesso limitarsi a cercare, diffidando innanzi tutto di quelli che hanno già trovato. Un tempo di sperimentazione diventa sempre più necessario. E anche quando la soluzione ci sarà, bisognerà guardarsi dalla tentazione di fissarla in una definizione definitiva. Vediamo intanto, per processo negativo, che cosa il partito non deve essere. Non deve essere partito socialdemocratico di opinione, – meccanismo di controllo delle masse, apparato di governo o di opposizione in funzione delle esigenze razionalizzatrici del capitale. Non deve essere partito rivoluzionario minoritario, – palestra di esercitazioni estremistiche, dove si distrugge il sistema a parole, ma nei fatti non si arriva a colpirlo. Non deve essere partito «storico» del movimento operaio, con tutto quello che ha comportato e comporta: autonomia della macchina burocratica, manovra centralizzata del consenso di base, eternità dello schema organizzativo, irrevocabilità dei dirigenti. Vediamo invece quali sono i connotati positivi che ci rimangono dal passato e che dobbiamo prendere in eredità. Non si deve trattare di principi teorici astratti, ma di premesse politiche concrete, di fatto. La prima di queste premesse politiche è il partito di massa. Di qui non si può tornare indietro. Si deve anzi spingere avanti questa realtà, verso una sua effettiva piena realizzazione. Un partito di quadri, un’organizzazione chiusa di specialisti della politica, è oggi improponibile, contrasta con le tendenze di fondo a una politicizzazione sempre più vasta che sale dal basso. La politica come specializzazione, il mestiere del politico come professione, sono residui borghesi che vanno aspramente combattuti. La nozione di «ceto politico» è una necessità da capitale che non può essere, non deve essere, una necessità per la classe operaia. Dal punto di vista operaio la politica è un interesse di massa e una funzione sociale esercitata dalle masse. La classe operaia è classe politica per sua natura storica. Quanto più avanza la crescita della classe, tanto più chiede di realizzarsi questa sua propria natura. Ecco perché ogni forma di democrazia indiretta, rappresentativa, delegata, ogni tipo di separazione istituzionale tra dirigenti e masse, ogni modello di organizzazione centralizzata, professionistica, burocratica, se sono cose che valgono per livelli arretrati di sviluppo della classe operaia quando e in atto il processo materiale della sua formazione, non valgono più e entrano in crisi e provocano rotture violente se non vengono abbandonate quando lo sviluppo ha consegnato alla classe la sua autonomia, la sua interna coesione, la sua figura esterna di minaccia politica diretta al sistema. Sopra abbiamo detto: non si può fare a meno subito di chi dirige. Si può cominciare però a fare a meno della funzione di direzione per rappresentanza degli interessi. Qual è il difetto del centralismo democratico? È di essere ancora nei casi migliori, una forma di democrazia rappresentativa, cioè un tipo di organizzazione politica pre-operaia. Questo cammino oggettivo, di fondo, interno alla nostra classe, di abbandono delle elites politiche, di assunzione in proprio, al limite da parte di ogni membro della classe, della funzione di direzione, questa tendenza rivoluzionaria nel senso più alto della parola, non bisogna rinviarla, perché si realizzi, alio stato operaio. Una politicizzazione universale, come interesse di massa alla politica e come esercizio di massa della politica, non ci sarà nello stato operaio se prima non ci sarà stata nel partito operaio. È oggi che s’impone, e subito, la fine della distinzione tra partito legale e partito reale. Vuol dire tutto questo rinuncia all’organizzazione? No. La seconda premessa politica che dobbiamo riprendere e salvaguardare è la macchina organizzativa, un meccanismo provvisoriamente stabile di decisione, di controllo e di esecuzione dell’interesse di classe, della volontà di classe. Questa macchina deve rispondere ai requisiti della produttività politica e dell’efficienza pratica. Soprattutto qui «è necessario essere assolutamente moderni». Qualcosa dalla prodigiosa macchina economica del capitale maturo dobbiamo pure imparare. E allora. Dal basso verso l’alto: razionalizzazione nelle fasi di passaggio per la conoscenza di ciò e, cioè del livello reale della lotta di classe, dell’interesse particolare degli operai in quel momento dato; eliminazione dei tempi morti che ritardano questa conoscenza; lotta contro lo spreco di materiale umano nella formazione sempre provvisoria del gruppo dirigente. Dall’alto verso il basso: calcolo il più possibile scientifico della consistenza di una situazione, dell’efficacia di una decisione e della sua corretta praticabilità; spirito non più pionieristico da vecchio capitalismo concorrenziale, ma iniziativa che segue l’analisi, scelta che viene fuori dalla ricerca, in una condizione che sarà sempre più oligopartitica, e entro un processo al tempo stesso di diffusione della proprietà dell’organizzazione tra le masse di lavoratori generici e di concentrazione del controllo nelle mani della sola classe operaia. Partito di massa dunque e non di quadri da un lato, efficienza produttivistica della macchina organizzativa dall’altro lato. Sembrano obiettivi contraddittori. Ma se pensiamo al partito di massa effettivamente diretto dalla classe operaia, allora vediamo la contraddizione sparire.
Si riducono a due oggi i grossi filoni su cui si tenta con una certa serietà la soluzione al problema del partito: li possiamo definire democratico l’uno, tecnocratico l’altro. Il filone democratico vive in questo periodo una sua nuova giovinezza. In ogni lotta, anche la più lontana dal terreno operaio, troviamo ormai momenti di democrazia diretta, di regime assembleare, istanze consiliari o soviettiste, esigenze autodecisionali e autogestionali. La lotta operaia di questi ultimi anni, che ha senz’altro implicita in sé questa tematica, è riuscita a trasportarla poi fino al livello politico formale. In essa va intanto salvata la richiesta politica egualitaria che vi sottende, la rinuncia a qualsiasi tipo di organizzazione burocratica, la critica a ogni direzione delegata del movimento. Ma risulta ancora molto impreciso il discorso sull’effettivo funzionamento pratico, moderno, di questa democrazia di base, e quindi invecchiato proprio il richiamo ideale, da prima parte degli anni venti, che non tiene conto di quanto è mutato da allora il volto della società capitalistica e di quanto è cresciuto il livello della classe operaia. La soluzione tecnocratica al problema del partito è meno visibile ad occhio nudo, si fa vedere meno in giro, non sembra esattamente questo il suo momento, vive nascosta negli uffici della direzione, si sviluppa nei centri-studi, esce allo scoperto solo nei seminari. Ma un’ala manageriale è pronta a prendere tutto il potere nel partito quando la vecchia guardia bolscevica sarà materialmente sparita. Non tutto è naturalmente da respingere. Anche qui c’è qualche cosa da salvare: la volontà ammodernatrice delle strutture organizzative, l’attenzione ai criteri di economicità, l’uomo giusto al posto giusto, e in più l’empirismo, la fine di ogni credo ideologico, quello che una volta si elogiava come «spirito pratico americano». Ma certo per questa via il legame con gli interessi immediati ed elementari della classe si perde e svanisce, l’autonomia del gruppo dirigente dalle spinte di base diventa molto più assoluta che in qualsiasi direzione paleoburocratica, il momento della lotta diventerà sempre meno importante rispetto al momento della contrattazione, la contestazione meno importante della gestione, l’opposizione meno importante del governo, e si sa di qui dove si finisce per arrivare. Verso queste due soluzioni-principe al problema del partito occorre tenere lo stesso atteggiamento che verso i lasciti ereditari delle due grandi correnti storiche del movimento operaio. L’egualitarismo democratico di base e di massa è quanto residua, malgrado tutto, dalla tradizione migliore del movimento comunista: è necessario riferirsi ad esso, spingerlo avanti e semmai correggerlo per farlo esprimere in forme e dentro strutture moderne. L’efficienza tecnocratica di vertice è quanto di meglio ci rimane del passato di organizzazione della socialdemocrazia: è conveniente prenderla freddamente nelle nostre mani, rovesciandola poi in una funzione pratica dei movimenti di lotta dell’interesse di classe. Partito di massa diretto dalla classe operaia vuol dire appunto che, al suo interno, proprio tutto il potere direttamente agli operai garantisce le strutture produttive, efficienti e moderne di questo potere, vuol dire un’organizzazione di base che riesce a tenere dentro di sé l’obiettivo della rivoluzione e il modello dell’industria, una sorta di meccanismo industriale per una politica rivoluzionaria. È per questa via che va forse cercata la forma del partito nuovo. Il discorso politico sulla classe operaia, su dove cadono i confini che la separano dal resto delle masse del popolo, sul nuovo rapporto di oggi tra operai e lavoratori nel capitalismo maturo, – questo discorso non mancheremo di riprenderlo a tempo opportuno, dopo questa galoppata sui problemi di linea, di organizzazione e prossimamente di strategia internazionale del movimento operaio. Ma le tre connotazioni intanto di produttività, di efficienza, di modernità, credo nessuno sia in grado di toglierle alla classe operaia. Si pone piuttosto qui l’altro problema: in che modo la classe operaia arriva a dirigere effettivamente il partito di massa. È noto come la formula della «funzione dirigente della classe operaia» non è mai sparita, almeno finora, dal rituale giaculatorio dei partiti comunisti e dei paesi socialisti. Come darle ancora, malgrado questo, un significato di verità? La cosa è tutt’altro che facile. Prima di tutto perché gli operai, ammaestrati dalle passate esperienze, diffidano di questa formula, come di tutte le formule che vogliono imbarcarli in un tipo di attività direttamente politica, ma completamente formale. In secondo luogo perché i canali di comunicazione, nelle attuali istituzioni, sono interrotti proprio e fondamentalmente nel passaggio che va dalla fabbrica al partito, dalla classe operaia alla sua cosiddetta organizzazione politica. S’è già detto una volta che il partito non entrerà in fabbrica se prima la fabbrica non sarà entrata nel partito, se non sarà salita cioè al centro della politica del partito. Si può aggiungere che effettivo rinnovamento di quadri non ci sarà se una nuova leva di dirigenti di estrazione direttamente operaia non salirà ad occupare posti di responsabilità nell’organizzazione di partito. Il che non vuol dire trasformare l’operaio singolo in rappresentante del popolo, vuol dire mettere in grado la massa operaia di esprimere dei dirigenti operai. Se è vero che la classe operaia è la nuova classe politica del mondo moderno, se è vero anzi che il concetto di classe politica è proprio esclusivamente della classe operaia, – allora dentro di questa, e soltanto dentro di questa, è risolto il problema della rappresentanza politica, perché potenzialmente non solo ogni operaio è membro del partito, ma è dirigente del partito. Il partito deve quotidianamente scavare entro questa inesauribile miniera di quadri, in modo da rinnovare sempre sé stesso, la propria organizzazione, il materiale umano della propria direzione. Questa è la grande superiorità del partito operaio sulle formazioni politiche di parte capitalistica. La crisi del ceto politico capitalistico, di cui sopra abbiamo parlato, è oggi crisi di reclutamento di personale politico che sia al tempo stesso efficiente e fidato, ed è anche crisi di formazione di questo personale che non possiede mai immediatezza di azione politica ma deve ottenerla dall’iniziativa in grande del capitale in quel momento dato. Di fronte a questo bisogna far risaltare le immense riserve di materie prime politiche che il partito operaio possiede nella sua classe, e la facilità con cui può lavorarle subito nell’azione pratica, mettendo in movimento il naturale, storico, immediato, istintivo comportamento politico delle masse operaie come tali. È vero e c’è da ripeterlo: gli operai vogliono il potere per garantire l’avanzamento del livello di vita, il miglioramento delle condizioni di lavoro. Questo è il rapporto di lotta di classe che oppone oggi gli operai al capitale. Più salario, meno lavoro, quindi il potere. Qui la classe operaia è il movimento concretamente sovversivo, in un dato momento, della categoria economica che mette in crisi lo stato del capitale. Diverso è il rapporto di organizzazione tra gli operai e il partito. Qui la politica sta veramente al primo posto. La questione del potere precede. La prima istanza operaia nei confronti del partito è un’istanza di direzione del partito. È qui che la classe operaia vale immediatamente come realtà politica. Donde due conseguenze: il partito è necessario alla classe operaia perché qui essa può esprimere direttamente la propria natura politica; il partito per la classe operaia è il contrario di quello che sono le istituzioni politiche in genere per il capitale. Distinzione, neppure formale, di un ceto politico dalla classe che lo esprime, non si dà più. Si dà anzi, appunto, l’opposto: unificazione, sempre in processo, tra composizione di classe e organismi di partito, che si realizza attraverso un continuo ricambio organico di uomini tra classe e partito. È soprattutto la separazione tra dirigenti e popolo, in quanto rapporto di governo, che assolutamente non deve ripetersi nel rapporto tra il partito e gli operai. Quando questo si ripete, questo è il segno della subordinazione politica dell’organizzazione cosiddetta di classe alle istituzioni della società capitalistica, è il segno della più paradossale contraddizione del nostro tempo, quella che fa stravedere tutti oggi sulla realtà di lotta della classe operaia: proprio questa che è la classe politica si trova senza partito. È necessario a questo punto ripetere che la soluzione pratica, diciamo pure tecnica, da dare poi a questi problemi è ancora tana dall’essere raggiunta, e che qui si vuole solo preparare un terreno di ricerca, sgombrando il campo dai detriti del passato e delimitando di nuovo l’orizzonte generale entro cui iscrivere in seguito concrete forme di funzionamento di una nuova macchina organizzativa. Questo vogliono dire le cose fin qui dette: che per il partito il luogo di nascita dell’iniziativa politica, il luogo di formazione della decisione politica va tutto trasportato a livello di grande fabbrica; che compito del centro è l’elaborazione dei dati di base e la loro sistemazione in una visione complessiva della situazione di classe compresa la misura delle forze in campo; che il problema delle alleanze tra la classe operaia e le altre parti del popolo si risolve oggi nel rapporto tra partito e altre organizzazioni sue alleate; che caduta del monolitismo all’interno e articolazione pluralistica di organizzazioni di lotta anticapitalistica all’esterno sono un medesimo e unico processo; che la democrazia diretta deve soprattutto imparare a funzionare e da organo di discussione deve diventare strumento d’azione; che l’assemblea operaia di massa solo così ha diritto di crescere a istituto politico fondamentale dell’organizzazione di partito, organo tassativo di controllo e di ratifica di ogni continuità e di ogni mutamento della linea, istanza deliberativa ed esecutiva nello stesso tempo; che gli operai devono cominciare a guidare la lotta dal vertice del partito e i dirigenti del partito dalla base della classe, – da queste e da altre cose, da questo decalogo incomplete e da completare si dimostra come e perché il partito si pone oggi come problema.
IL PRIMO ARTICOLO È CONSULTABILE AL SEGUENTE LINK:
MARIO TRONTI E LA RIVISTA “CONTROPIANO” (I) – ESTREMISMO E RIFORMISMO