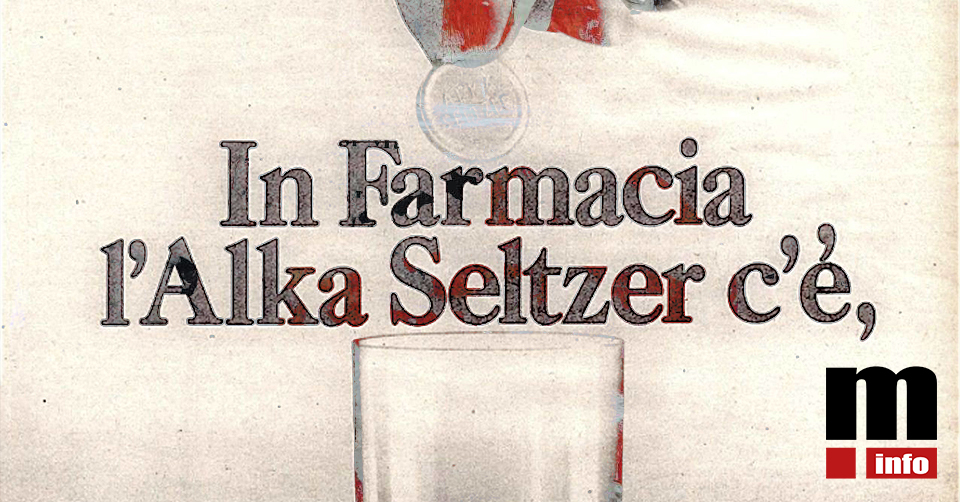Riprendiamo le nostre analisi sul lavoro pubblicando un editoriale de il Manifesto del 1° maggio del 1971. L’articolo, uscito senza firma, venne scritto da Lucio Magri. All’interno del movimento operaio ufficiale, l’intervento suscitò indignazione per lo scarso rispetto dimostrato verso le forze produttive del Paese ma a distanza di cinquant’anni reputiamo che le riflessioni di Magri, aldilà del riflesso ideologico del tempo, ci indicano una strada da percorrere per spezzare il meccanismo della riproduzione del capitale.
Il primo maggio non è la festa del lavoro, come dice e vuole la liturgia del movimento operaio riformista o clericale. È la festa contro il lavoro: contro il lavoro per ciò che esso è e sarà sempre in una società capitalistica, in una società divisa in classi, in una società mercantile. Questo i proletari non ci mettono molto a capirlo. E infatti, il solo modo che hanno di celebrare la loro giornata è quello di non lavorare. Il primo maggio è nato ed è vissuto per lunghi anni come uno sciopero, come uno scontro.
Non è una distinzione formale, una sottigliezza ideologica. Il problema del lavoro e dell’atteggiamento verso di esso è sempre stato il nodo profondo del marxismo: la vera discriminazione tra marxismo rivoluzionario e revisionismo.
Qual è il problema per i revisionisti? Quello di dare al lavoro la giusta remunerazione e di fondare una nuova civiltà del lavoro: chi non lavora non mangia. Qual è il problema per i rivoluzionari? Quello di abolire il lavoro salariato, cioè, oggi, il lavoro stesso, per costruire una civiltà fondata sulla libera e collettiva attività creatrice e su rapporti non mercificati fra gli uomini: a ciascuno secondo i suoi bisogni, da ciascuno secondo le sue capacità. Qui sta tutta la differenza tra socialismo come società capitalistica meno diseguale e più opulenta, e socialismo come rovesciamento del capitalismo dalle fondamenta.
Non si tratta, per il marxismo, di una ingenuità anarchica, del mito del buon selvaggio. Nessuno più di Marx ha fatto del lavoro il centro motore della storia, l’uomo stesso è il prodotto del suo lavoro. Ma proprio col suo lavoro l’uomo ha dominato la natura, ne ha decifrato le leggi, ha trasformato se stesso fino al punto in cui può rovesciare la storia e liberarsi dal lavoro come prima e ultima schiavitù, come qualcosa di estraneo a lui, di accettato per la necessità della sopravvivenza.
Il capitalismo è il momento storico in cui questa contraddizione e la possibilità di superarla maturano insieme. Da un lato il lavoro diventa, come lavoro salariato, fino in fondo e per tutti una realtà esterna, senza senso e contenuti, una alienazione insopportabile; dall’altro esso ha ormai prodotto un livello di forze produttive, prima fra tutte la capacità razionale dell’uomo, che consente il salto ad un ordine sociale in cui il lavoro, per ciò che è stato fin qui, sia soppresso. Soppresso non per lasciar posto ad un ozio stupido e al faticoso “tempo libero” – che è solo l’altra faccia del lavoro alienato – ma ad un complesso di libera attività collettiva e di riposo creativo di una nuova capacità.
Di tale attività, la produzione materiale dei mezzi di sussistenza può diventare un sottoprodotto naturale, progressivamente affidato alle macchine, che non giustifica assolutamente più né lo sfruttamento economico né la dominazione politica. Questa è l’essenza della rivoluzione comunista, della soppressione della proprietà privata, delle classi e dello stato. Ribellione alla condanna biblica: tu lavorerai con fatica.
Non è un caso che questo nucleo radicale del marxismo sia stato dimenticato o sia rimasto minoritario nel movimento operaio. Gli operai, come tutti gli uomini, possono porsi solo i problemi che sono effettivamente in grado di risolvere. Solo nella nostra epoca, della piena maturità del capitalismo e della sua degenerazione imperialistica, le grandi masse dell’occidente che hanno avuto dallo sviluppo capitalistico tutto ciò che potevano avere pagandolo con lo sfruttamento, e le grandi masse dell’oriente che dal capitalismo potrebbero avere solo fame e guerra, possono porsi realmente il problema del comunismo. Cioè il problema non solo di maggiore consumo e di lavoro sicuro, ma di un diverso significato del lavoro e del consumo. Qual è, se non questo, il senso profondo delle lotte di massa di operai, studenti, intellettuali degli ultimi anni? Qual è, se non questo, il significato universale della rivoluzione culturale cinese?
Certo, tutto ciò può anche alimentare spinte ingenuamente neoanarchiche, l’illusione che si possa abolire il capitalismo d’un colpo; ribellarsi alla logica della produzione e `rifiutare il lavoro’ con un atto di ribellione soggettivistica e distruttiva; o usare delle macchine e degli uomini così come sono per una organizzazione comunista della società, senza una lunga e faticosa trasformazione delle une e degli altri, senza una società di transizione, e dunque senza organizzazione, violenza, sacrificio, invenzione, educazione. Ma ciò che oggi importa, come importava per Lenin, è cogliere in queste spinte “ingenue” il nucleo di verità che oggi è maggiore di ieri, e senza del quale non è più possibile sfuggire all’egemonia ideale del capitalismo.
Questo vogliamo ricordare il primo maggio: per riscoprirne fino in fondo il significato di festa politica, di festa rivoluzionaria.