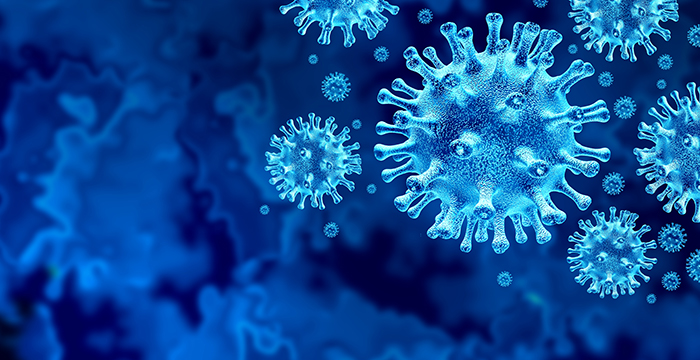di Domenico Bilotti
La quarantena è una forma di compressione delle libertà individuali che origina da un bisogno sostanziale ritenuto meritevole di maggiore protezione: l’isolamento dei fenomeni epidemici. “Quarantena” deve il suo nome alle quaranta giornate di isolamento che spettavano nel XIV secolo (ma esistono usi simili anche precedenti) alle navi che giungevano da porti e zone colpiti dalla peste. La misura di isolamento aveva una utilità sociale che sarebbe inutile nascondersi: sui contagiati o sui presunti contagiati in attesa di accertamento, far trascorrere un ragionevole lasso di tempo significa chiarire se l’infezione vi sia stata e se, avvenuta, possa essere guarita e in che modi. La propagazione di un’epidemia ha bisogno di vettori. Gli assembramenti o le pratiche scarsamente igieniche inevitabilmente la rafforzano. Non ci dovrebbe essere bisogno di chiarirlo. E tuttavia, accanto alla quarantena come uso sociale necessariamente residuale meritoriamente protettivo, se ne è affacciato un uso di contenimento politico spesso contraddittorio rispetto agli stessi scopi di salute pubblica. Forme di “quarantena”, anche se non si chiamavano così, venivano applicate nei secoli precedenti anche nei confronti dei lebbrosi. Il che appariva curioso in una civiltà giuridica che riteneva spesso necessario che il coniuge lebbroso compisse comunque l’atto coniugale – con i rischi di contagio alla prole e alla parte sana. A lungo tempo, poi, il lebbroso finì per essere ritenuto di un disvalore etico collettivo infinitamente superiore alla già grave barriera che era necessario imporgli intorno per chiudere la malattia – sempre che vi si riuscisse. Se guardiamo alle malattie contagiose, la disciplina positiva e le prassi viventi del diritto amministrativo ci sono illuminanti. Alla metà degli anni Ottanta, alcuni coraggiosi reportage de l’Espresso documentavano la stretta che nei parchi milanesi affliggeva, novelle appestate, giovani prostitute e tossicodipendenti: la società del tempo s’era accorta tardivamente della enorme pericolosità della sieropositività e correva ai ripari additando preventivamente tutte le categorie del rischio sociale. Comprese quelle meramente presunte e non concretamente affette. La quarantena in lingua italiana si chiamò a lungo “contumacia”. Coincidenza o scelta di politica legislativa civile e penale? Nel diritto processuale vigente, il contumace è chi omette di costituirsi davanti al giudice che esamina un processo a suo carico, pur essendone obbligato. Tanto la “contumacia” quanto la “quarantena” indicano perciò una situazione di difetto, di assenza “gestita”, di giudizio morale negativo sull’assente, sino alle soglie di una sua diretta colpevolezza. Contumacia, nel latino tardo, era la condizione di ostinata disobbedienza; era una forma di renitenza rispetto al giudizio e alla sentenza. La quarantena, in secoli a noi più vicini, fu riservata ai malati di colera o di febbri tropicali, persino, nel diritto inglese e non solo, agli animali da esportazione. Molte volte si è trattato di misure assolutamente necessarie; in tante altre, ormai, la quarantena era diventata un formulario, un adempimento amministrativo, un limbo procedimentale privo di congruenza medica effettiva. Una dimostrazione di immobilizzazione dei tempi e dei luoghi. La ragione ritorsiva dell’imposizione della quarantena era chiara, e chiara si è mantenuta ad esempio nel diritto migratorio del XX secolo: isolare, schermare, sottoporre a uno specifico caso di soggezione. Che cosa dovremmo tesaurizzare per edificare un futuro radicalmente altro, che perdipiù sia in grado di abbattere le condizioni di diffusione dei virus? Le ragioni dell’isolamento devono essere esaustivamente chiare a chi le subisce: altrimenti le violerà. Non per trasgressione politica costituente, ma per fisiologica incapacità di valutarne la necessarietà. È questa asimmetria informativa il vettore immateriale di ogni contagio di massa. L’attività di inquarantenamento deve essere slegata dalla delazione di altri consociati, altrimenti si rimette alla sola istanza di parte di far scattare un regime derogatorio di libertà fondamentali. Terzo e ultimo: il divieto è un potente strumento di regolazione politica. Soltanto il convincimento di ottemperanza all’obbligo ingiusto è più forte (il prigioniero di 1984 muore dopo aver riconosciuto che due più due fa cinque; il signor K. lascia questa terra ormai convinto di avere una colpa da espiare per la quale contro di lui si doveva procedere; ben diversamente Galileo bisbiglia il suo timido ma fermo “eppur si muove”). Ergo, l’utilizzo del divieto deve avvenire secondo proporzionalità, garanzia e finalità. Altrimenti diviene un generico “chiudere tutto” che apre soltanto il terribile vaso di Pandora.